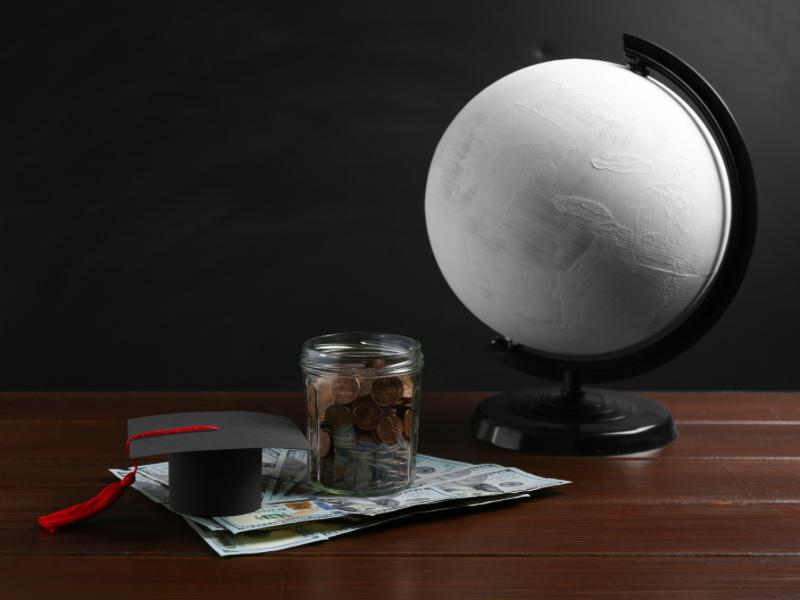
Lineamenti di una pedagogia a orientamento clinico.
Debora Di Jorio
Quella pedagogia che accompagna l’individuo nell’incontro con l’ambiente potenziando in entrambe le possibilità di crescita e apprendimento è una Pedagogia “Clinica”. Senza voler conferire a questo binomio alcun inutile intento di carattere sanitario, la Pedagogia si impreziosisce tautologicamente dell’uso di un rafforzativo che riconduce la relazione educativa alle radici etimologiche che la caratterizzano nonché a storici esempi di pedagogisti come la Montessori, che hanno teorizzato principi ancora oggi validi e ampiamente riproposti, attenti in primo luogo all’osservazione dell’intero sviluppo della personalità umana per una pratica educativa che emerge dal campo della relazione e da un solido patrimonio culturale di natura sia scientifica che umanistica. L’obiettivo di una pedagogia a orientamento clinico parte proprio da qui, dal coniugare il complesso bagaglio di una solida cultura proveniente dallo studio delle scienze naturali come dalle scienze umane, con gli strumenti operativi di quell’intervento che, piegandosi sulla persona con uno sguardo attento al panorama eterogeneo delle possibilità, chiamiamo clinico perché rispettoso della narrazione del testo individuale, dei suoi bisogni, ma anche di un testo collettivo, del panorama relazionale e antropologico cui l’individuo appartiene e di cui è l’inalienabile risultante.
Pedagogia Clinica – formazione – età evolutiva
Le professioni di aiuto escono delineate dai percorsi accademici con fisionomie storiche, antropologiche e culturali che ne accompagnano da sempre la natura e le finalità e non possono prescindere dalle basi etimologiche che ne contraddistinguonola terminologia.
La pedagogia non può rivendicare il suo impianto epistemico quale scienza della formazione che in quanto tale presiede le scienze dell’educazione, precludendo l’accesso a un sapere fondato anche sul bagaglio semantico d’origine da cui attingere i necessari riferimenti.
Essa si riveste di connotazioni e arricchimenti linguistici in ciascunodei luoghi di crescita umanain cui è chiamata ad agire. Quella pedagogia che accompagna l’individuo nell’incontro con l’ambiente potenziando in entrambi le possibilità di crescita e apprendimento èuna Pedagogia “Clinica”. Senza voler conferire a questo binomio alcun inutile intentodi carattere sanitario,la Pedagogia si impreziosisce tautologicamente dell’uso di un rafforzativoche riconducela relazione educativaalle radici etimologiche che la caratterizzano nonché a storici esempi di pedagogisti come la Montessori,che hanno teorizzato principi ancora oggi validi e ampiamente riproposti, attenti in primo luogo all’osservazione dell’intero sviluppo della personalità umana per una pratica educativa che emerge dal campo della relazione e da un solido patrimonio culturale di natura sia scientifica che umanistica. Chiunque dunque afferisca a una professione educativa e si pieghi con il corpo e con lo sguardo verso l’Altro accogliendone l’esigenza di essere accompagnato in un percorso di crescita,fa un intervento clinico, nel caso specificopoggiante su uno sfondo di natura pedagogica.
La lingua greca antica, affascinante riflesso di un popolo unito solo nella koinè e nella religione e specchio di quella stessa civiltà che ha dato i natali alla pedagogia e alla prima vera cultura pedagogica, distingueva con accuratezza il contesto diun agireclinico da un intervento diremmo oggi sanitario, differenziando il verbo iatreuo,medico, curo con medicamenti, dal verbo klino,curo, mi piego su, mi volgo verso qualcosa, qualcuno,conferendo, come era solito fare un greco, all’azioneumana la sacralità dell’accoglienza nella piena concretezza del movimento,del gesto e del contatto diretto, ma anche e soprattutto la specificità del contesto spaziotemporale in cui quest’atto si dispiegava, cosa che per i greci era sempre rappresentato dall’ hic et nunc,osservato da una prospettiva lontana dalla quantificazione e dal tempo misurato in passato e futuro, e fedele soltanto a un incessante divenire al quale si riconosceva nel presente la sola possibile realtà descrivibile e a cui non si imponevano previsioni deterministiche affidate esclusivamente alla volontàdivina.
Una visione educativache nel limite stesso del proprio sguardo temporalmente confinato in quel dove e in quel quando, individuava le mille possibilità di cambiamento, che nell’umiltà socratica del non sapere riusciva a nutrire fiducia nella continua scoperta pur rimanendo rispettosa di ciò che non è dato conoscere dagli strumenti di indagine della ragione e che resta privo di risposta.
Ed ecco che la Pedagogia si fa scienza del come ridisegnando nell’interazione uno sviluppo che viene accompagnato, descritto, guardato, ri-progettato e mai ultimato, restando fedele alla sua cornice storico- culturale da cui ricavare, se vogliamo, una legittima terminologia e un criterio terapeutico inteso come cura dell’altro.
Da qui la necessità di accompagnare la crescita di un bambino mediante quelli che vengono definiti processi educativi di cui l’adulto è spettatore interagente e nei quali, più di quanto forse sia consapevole,può plasmare abilità, costruire autonomie, esercitareesperienzeche traggono beneficio dalla plasticità neuronale ricalibrando proprio grazie al campo relazionale,tracce mnestiche in funzione di sempre nuovi adattamenti.Questo il valore della relazione al quale la pedagogia clinica riconosce il potenziale sano e prezioso, ma, va ricordato, anche quello che può assumere caratteri distruttivi se coltivato in un background inadeguato.Studi neuroscientifici confermano che l’apprendimento si consolida grazie a circuiti cerebrali strettamente interconnessi con strutture a loro volta coinvolte nella motivazione, nei processi decisionali e negli stati emotivi che non possono prescindere dall’incontro tra biologia individuale e contesto ambientale di riferimento.
Kurt Lewin ricorda nella sua teoria del campo,che le cause della natura di un evento non vanno ricercate nel singolo oggetto, ma nella relazione che si instaura tra questo oggetto e l’ambiente che lo circonda esimilmenteMerleau Ponty (1945):Io sono come mi vedo, un campo intersoggettivo, non malgrado il mio corpo e la mia storia, ma perché io sono questo corpo e questa situazione storica per mezzo di essi. (p. 515)
La conoscenza di questo corpo e di questa storia per il professionista dell’educazione e della relazione d’aiuto, riconduce a uno sfondo interdisciplinare su cui poggiare trasversalmente l’impianto epistemologicoseguito. Qualsiasi esso sia, qualsiasi sia l’orientamento professionale scelto dal pedagogista, i saperi di riferimento devono necessariamente toccare le diverse interpretazioni dello sviluppo umano e della sua condizionecosì come concepite dalla filosofia, dalla storia, dall’antropologia, dalla letteratura, dalla psicologia, e dalla medicina con particolare attenzione alla neurobiologia e alla psichiatria.
L’obiettivo di una pedagogia a orientamento clinico parte proprio da qui, dal coniugare il complesso bagaglio di una solida cultura proveniente dallo studio delle scienze naturali come dalle scienze umane con gli strumenti operativi di quell’intervento che, piegandosi sulla persona con uno sguardo attento al panorama eterogeneo delle possibilità, chiamiamo clinico perché rispettoso della narrazione del testo individuale, dei suoi bisogni, ma anche di un testo collettivo, del panorama relazionale e antropologico cui l’individuo appartiene e di cui è l’inalienabile risultante. Da un retaggio intimamente kantiano essa riprende la necessità di un fondamento conoscitivo desumibile solo dall’incontro della forma quale necessario impianto gnoseologico e cornice di senso, e il contenuto come indispensabile prodotto dell’esperienza empiricamente acquisita sul campo. La pedagoga clinica è anche una pedagogia del tempo, prima di tutto capace di chinarsi sulle possibilità concesse dalle tappe del tempo misurato, krònos, ma di cogliere con pazienza l’evolversi di quello opportuno kairòs, in uno spazio che è sempre spazio condiviso, all’interno di una logica del confine che non va confusa con un’ottica restrittiva delle opportunità umane, ma al contrario profondamente salda nella consapevolezza che qualsiasi limite contingente può essere superato solo all’interno di quel con-testo che è dato concedere all’uomo e che sarà sempre costituito da contorni ben definiti che la relazione educativa deve essere in grado di cogliere, proprio in ragione di quell’equilibrio e senso della misura cui l’uomo tende naturalmente per raggiungere il suo bene-essere.
Èproprio per questo la pedagogia clinica si propone anche come scienza del con-tatto, dell’azione concreta basata sull’esperienza di apprendimento tangibile, è dunque per questo scevra dall’utilizzo indiscriminato e poco contestuale degli strumenti digitali e delle realtà virtuali. Come già sosteneva Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) l’apprendimento è raggiunto con il cuore, con la mente e con le mani, e questo vale anche e soprattutto per chi questo apprendimento deve trasmetterlo e mediarlo senza affidarsi all’intermediazione spesso impropria, di strumenti che sebbene rispondano con maggiore efficacia e rapidità alla richiesta di gratificazione emotiva specialmente di natura visiva, talvolta paventano, con questo criterio, soluzioni miracolistiche per il superamento di qualsiasi difficoltà, difficoltà che separate dalla cornice storica e ambientale dell’individuo fanno presto a mutarsi pericolosamente in molti casi in disturbo, e il disturbo, come la malattia, corre il rischio di essere privato, nella connotazione oggettiva attribuitagli, di luogo, storia e individualità. Trovare la risposta nella specificità dei canali funzionali e nella caratterizzazione degli stili di apprendimento è compito di chi fa educazione e si affida al valore esclusivo della drammaturgia della relazione fatta di sguardi, voce, registri comunicativi, intenzionalità gestuale, mutamenti e improvvisazioni, inimitabile repertorio umano volto a impreziosire l’esperienza giorno per giorno e dunque a strutturare, alimentare e consolidare l’apprendimento e tutto ciò che esso contiene in termini di attenzione, memoria, pianificazione, motricità, percezione e linguaggio; un traguardo che si ottiene a caro prezzo e in tempi non pronosticabili in cui l’esperienza non può che individuare nel confine il proprio compagno di viaggio e la migliore sorgente di risorse.
Nella Critica della Ragion Pura Immanuel Kant coglie splendidamente questo aspetto, relativistico quanto profondamente umano, dell’anelito alla conoscenza, nella similitudine del volo della colomba:
La colomba leggera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di aria. E appunto così Platone abbandonò il mondo sensibile, poiché esso pone troppo angusti limiti all’intelletto; e si lanciò sulle ali delle idee al di là di esso, nello spazio vuoto dell’intelletto puro. Egli non si accorse che non guadagnava strada, malgrado i suoi sforzi; giacché non aveva, per così dire, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui potesse applicare le sue forze per muovere l’intelletto. Ma è un consueto destino della ragione umana nella speculazione allestire più presto che sia possibile il suo edifizio, e solo alla fine cercare se gli sia stato gettato un buon fondamento. Se non che, poi si cercano abbellimenti esterni di ogni specie per confortarci sulla sua saldezza, o anche per evitare del tutto tale tardiva e pericolosa verifica.
(Kant, 2000, p. 38)
Dunque, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui potesse applicare le sue forze per muovere l’intelletto, quell’appoggio che nella relazione con l’ambiente diventa appunto ostacolo nutriente alla crescita contro il quale impattare le nostre capacità ricavando da questo scontro la possibilità di misura, confronto e autopercezione e senza il quale qualsiasi forma di consapevolezza sarebbe impossibile.
Nel suo libro Neuropedagogia: Cervello, esperienza, apprendimento Alberto Oliverio (2015)scrive: “L’educazione ha il compito di dare forma al cervello” sintetizzando in queste parole il più elevato assioma di una pedagogia clinicamente intesa, ovvero una neuropedagogia inevitabilmente connessa ai contributi delle ricerche neuroscientifiche e sempre aggiornata sull’evoluzione dell’attività del sistema nervoso umano per regolare al meglio il proprio contributo qualitativo sia in ambito epistemologico che nella prassi educativa, avendo come unico fine la salute umana.
Negli anni cinquanta un medico statunitense Edward Bernard Le Winn (1969)definì il percorso che compie l’organizzazione neurologica del sistema nervoso attraverso le sue tappe di sviluppo: il processo mediante il qualel’ organismo soggetto a forze medioambientali consuma il suo potenziale inerente al suo codice genetico. Ecco perché qualsiasi progetto educativo non può non tenere conto che ciascuno di noi sia il frutto di questo incontro e scambio incessante senza rimanere assolutamente inconsapevole e poco padrone delle modalità riversate nel campo relazionale che non possono non essere alimentate da una conoscenza costruttiva così come da una sempre rinnovata creatività capace di diversificare attività e stimoli in spazi e tempi adeguati, collocati in una prospettiva professionale chiara e consapevole.
Nel suo famoso libro So quel che fai il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti (2006) citando Husserl,membro della Scuola di Brentano e fondatore della fenomenologia in quanto approccio alla filosofia che assegna un ruolo di primo piano all’esperienza intuitiva che guarda ai fenomeni come inesorabilmente legati al nostro punto di vista, ricorda:
l’impiego diuno strumento lo lega al nostro corpo come se fosse un’estensione di uno dei suoi organi non però di un organo nuovo giacché tale legame viene limitato dall’uso effettivo che di quello strumento vien fatto.(Husserl, 1931)
Possiamo pertanto consentirci di dire che questo uso effettivo di un qualsiasi oggetto che il bambino apprende e che permette alle sue abilità sensorimotorie di esplicitarsi, viene necessariamente mediato dalla relazione educativa e da quello specchio di reti neuronali che apre al bambino la possibilità di fare proprio ciò che vede per poi riutilizzarlo. Un esempio potrebbe essere rappresentato dall’acquisizione del gesto grafico e dell’utilizzo degli strumenti di scrittura come forma umana peculiare di insegnamento ed espressione di sé, uno schema fino-motorio così complesso nella sua sequenzialità da consentire il raggiungimento di elevati livelli di concentrazione e di assimilazione di contenuti, potenziando mediante un atto creativo fortemente integrato, l’attività cognitiva stessa e la maturazione di apprendimenti scolastici ma non solo, collocandosi nel panorama eterogeneo delle potenzialità umane più sofisticate, funzionali alla salute e al benessere della persona di qualsiasi età.
La pedagogia clinicamente orientata si pone al centro di questo processo di comprensione, lo osserva e lo interpreta in una campo relazionale contestualizzato e mirato, così come accade per tante altre abilità destinate a costituire la fonte di risorse che ogni persona trasferirà nel comportamento e dunque nei suoi legami sociali, perché l’apprendimento è sempre il prodotto di contatti umani che hanno lasciato traccia, a vantaggio tutto di una neurogenesi che vede nella solitudine e nell’abbandono della cura le sue peggiori reali minacce, foriere di morte prematura dell’autonomia e della libertà individuale.
Lo stesso Rizzolatti citando le parole di Merleau Ponty riporta:
i luoghi dello spazio devono essere intesi non come posizioni oggettive del nostro corpo, ma compresi, come ci insegna Merleau Ponty nel loro “iscrivere intorno a noi la portata variabile delle nostre intenzioni e dei nostri gesti”(Rizzolatti, 2006, p.77)
dinamiche che non coinvolgono soltanto il nostro corpo e gli oggetti che gli stanno intorno bensì anche il corpo degli altri.
Questa possibilità che il pedagogista impegnato nella relazione clinica si dà di intuire le azioni altrui, discriminarle, condurne l’intenzionalità linguistica e comportamentale selezionando con cura registri comunicativi, gesti e nessi semantici si chiama ermeneutica.
Le scienze umane la insegnano nel liceo classico nel forgiare quella sensibilità che rende capaci di approcciarsi a un testo storico, letterario, antico e moderno, sia esso greco, latino, in stilnovo o in italiano volgare. L’esercizio di tale attitudine cui gli studi umanistici formano, si unisce nel sapere del pedagogista, alle fondamenta scientifiche delle diverse discipline da cui attingere quei principi che consentono un’attenta analisi dei contesti individuali e del campo relazionale senza cadere nelle prospettive pregiudiziali o nelle certezze di modelli precostituiti che solo all’apparenza sembrano rendere il lavoro professionale semplificato, perché fondamentalmente eseguito, per poi tramutarsi in una temporanea sensazione di conforto che si scontra con i presupposti di fondo dell’agire educativo e cioè che nel divenire umano non esistono prescrizioni e traguardi personalistici da perseguire, ma solo obiettivi condivisi quotidianamente. L’ermeneutica si fa allora strumento privilegiato della pedagogia clinica che ricondotta alle sue origini si pone lontana dalle misurazioni e dalle quantificazioni, affidandosi all’interpretazione del testo mediante l’arte dell’osservazione che pur orientata dalle prove strumentali ,in qualsiasi ambito professionale ci si trovi, non può sostituire con esse la dia-gnosi (da gnosi + dià, conoscenza attraverso) nella sua completezza, doverosamente filtrata dal contatto umano rivolto all’ascolto della narrazione del paziente, come già prevedeva Ippocrate, consegnando con le sue parole una grande lezione di fenomenologia alla storia della medicina nel dire: È più importante sapere che tipo di persona abbia una malattia, che sapere che tipo di malattia abbia una persona.
L’osservazione pedagogica utilizza anch’essa strumenti, prove contestualizzate, può diventare mirata e provocatoria, persino critica quando suscita azioni e reazioni anche selezionando stimoli specifici da spargere nell’ambiente, ma sempre al fine di descrivere e non misurare, quel modo unico tanto caro alla lingua del greco classico, in cui l’uomo sa esprimere se stesso, le abilità che emergono dalla riserva funzionale che nel corso della crescita ha dato struttura al suo habitus parzialmente stimabile, non esaustivamente conoscibile se non limitatamente a ciò che lo scambio relazionale concede.
Su questi principi di matrice neuropedagogica, ma sicuramente riconducibili a un impianto epistemico di natura fenomenologica e costruttivista, si basa l’osservazione dell’espressività funzionale, dell’incontro dell’individuo con oggetti, fatti e persone, e il progetto educativo che abilita competenze ancora inespresse, di una pedagogia a orientamento clinico, mirata all’esclusivo obiettivo di riconsegnare all’individuo, in primo luogo al soggetto in età evolutiva, la consapevolezza di possedere qualità capaci di strutturare in rinnovate progettualità e nuove forme di autonomia,la cura di sé.
A margine di queste riflessioni volte a dare per quanto possibile, una fisionomia più delineata alla professione pedagogica declinata in ambito clinico e attenta a processi di sviluppo neurofunzionali, mi affido con gratitudine alle parole del neurologo e scrittore Oliver Sacks, tratte dal suo romanzo Un antropologo su Marte:
…un bambino deficitario presenta un tipo di sviluppo qualitativamente diverso …se un bambino sordo o cieco raggiunge nello sviluppo lo stesso livello di un bambino normale significa che i bambini deficitari raggiungono lo stesso livello in un altro modo, per un’altra via, con altri mezzi e per il pedagogo è particolarmente importante conoscere lo speciale percorso lungo il quale deve condurre il bambino….questa grande capacità del cervello capace degli adattamenti più impressionanti perfino in circostanze particolarissime e spesso disperate di handicap neurale o sensoriale è arrivata a dominare la mia personale percezione dei miei pazienti e delle loro vita al punto che a volte sono spinto a chiedermi se non sia necessario ridefinire i concetti stessi di salute e malattia per considerarli non più i termini di una norma rigidamente definita, ma in quelli di una capacità dimostrata dall’organismo di creare un ordine e un’organizzazione nuovi, adatti alla sua disposizione e alle sue esigenze così particolari e alterate…oltre all’approccio oggettivo dello scienziato, del naturalista, occorre anche un approccio intersoggettivo…
New York giugno 1994 O.W.S.(Sacks, 2014, pp.17-21).
Se dovessi dare alla pedagogia clinica una fisionomia tratta dalla mia personale esperienza professionale, potrei citare diversi episodi significativamente simili fra loro e uno emblematico fra tutti di qualche tempo fa in cui una bambina con la quale mi trovai a condividere in alcuni incontri un progetto di potenziamento delle sue abilità di lettura, alla mia proposta di eseguire insieme un’attività, con un atto splendidamente creativo, immediato e spontaneo mi indicò le modalità in cui avrebbe potuto affrontarla riconducendomi con una preziosa lezione educativa a quella traità cara a Martin Buber per la quale “le anime non raccontano di se stesse, ma di ciò che su di esse ha agito; quanto apprendiamo dal loro racconto non appartiene perciò soltanto alla psicologia, ma alla vita”.
Riferimenti bibliografici
Husserl, E. (1931). Ideas (WR Boyce Gibson, Trans.). George Allen &Unwin: London.
Kant, I. (2000).Critica della ragion pura. Laterza: Roma-Bari 2000.
Le Winn, E. B. (1969). Human neurological organization. Thomas.
Merleau-Ponty, M. (1945).Phénomenologie de la perception. Gallimard: Paris.
Oliverio, A. (2015). Neuropedagogia: Cervello, esperienza, apprendimento. Giunti.
Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2006). So quel che fai: il cervello che agisce ei neuroni specchio. Cortina.
Sacks, O. (2014). Un antropologo su Marte: sette racconti paradossali. Adelphi.

